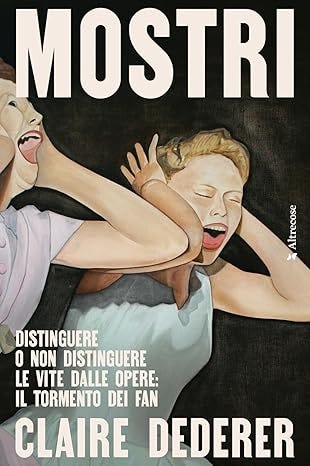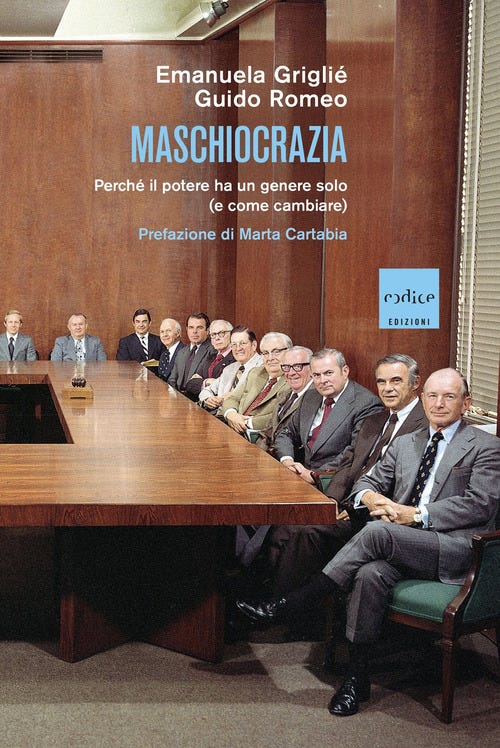Produco, dunque sono (?)
Ho scritto questo pezzo l'anno scorso, ma mi sembra ancora più attuale che mai.
Disclaimer: quello che segue è un pezzo d’opinione scritto circa un anno fa e uscito sul quotidiano La Svolta, non più accessibile.
Da qualche settimana la mia casella mail ha iniziato a risputarmi indietro out of office scritti, diciamo così, a diluizione omeopatica.
Me ne ero già accorta verso la fine di maggio, quando sono comparsi ə primə pionierə delle vacanze in alta stagione.
Cosa sono gli out of office?
Sono quei messaggi di testo che si impostano - e partono poi in automatico - per mettere a conoscenza le persone che lavorano con noi, per noi o per cui lavoriamo che siamo in vacanza.
Che non ci siamo.
Che non devono disturbarci mentre oziamo, nuotiamo, scaliamo vette sopra i 2000 o siamo rimasti a casa ad ammazzarci di gelati e serie tv (cosa che personalmente considero uno sport al pari degli altri citati).
Come diceva la voce narrante del film La Haine: fin qui tutto bene.
Il punto però è che abbiamo iniziato a edulcorare questi messaggi, scrivendo formule del tipo:
Ciao,
grazie per avermi scritto! Sfortunatamente non sarò in ufficio fino al xx luglio. Ti risponderò appena possibile.
oppure
Ciao, sono fuori ufficio con limitato accesso alle e-mail e rientrerò il xx agosto. Puoi scrivere a…
O anche
Grazie per la mail: potrò rispondere dopo il xx settembre
Mi pare evidente che abbiamo qualche leggerissimo problema di eufemismi, qui. È come se ci vergognassimo (in primis con noi stessi) anche solo di pronunciare la parola ferie e aggiungessimo sfumature di significato assolutamente non richieste a una comunicazione che, di per sé, dovrebbe essere neutra.
Non sarò in ufficio è diventato sinonimo di sono in vacanza? E perché questa dovrebbe essere un’occasione sfortunata? Cosa vuol dire esattamente con limitato accesso alle mail? Che mi tolgono il telefono quando arrivo in hotel? Che non mi porto il pc su cui c’è la posta dell’ufficio? E perché suona come una giustificazione che nessuno ha chiesto?
Forse, più prosaicamente, questa è solo l’ultima puntata- holiday edition- della sindrome di cui chiunque più o meno soffre e cioè il capitalismo interiorizzato:
“l’idea che la nostra autostima sia direttamente collegata alla nostra produttività"
come lo definisce Anders Hayden, professore di scienze politiche alla Dalhousie University in Nuova Scozia che sta conducendo ricerche sugli impatti politici sulle misure alternative di benessere e prosperità al di fuori del prodotto interno lordo.
Perché forse dovremmo ricordarcelo, che può essere possibile esser felici anche se per due settimane non contribuiamo al PIL.
Ma ne siamo capaci? Immersi in un contesto socio-economico che ci ricorda che se vuoi puoi e che il merito è davvero un ingranaggio del meccanismo?
Prima di profondermi oltre però confesso: io ero una di quelle che in vacanza si portavano il computer, perché non si sa mai. Ero quella che accettava le call di lavoro quando non avrei dovuto lavorare. Sono stata, e in alcuni momenti ancora lo sono- una che ha sofferto di Productivity Guilt: quel senso di colpa tutto capitalista che non ti permette- letteralmente- di assaporare il tempo vuoto. A mia discolpa devo dire una cosa però: è un po’ diverso per chi è freelance rispetto a chi ha un lavoro da dipendente, perché quello stesso tempo vuoto si traduce effettivamente in opportunità in meno e quindi in denaro in meno.
Perdere tempo prezioso (che potrebbe essere riempito con la possibilità di guadagnare di più) ci fa sentire in colpa. Eppure, l’ansia di staccare la spina non è certamente limitata a chi svolge la libera professione.
Un sondaggio del 2017 condotto da Glassdoor ha rilevato che più della metà degli americani non utilizza tutto il tempo delle vacanze, soprattutto a causa della paura. Non si prendono tutte le ferie che si maturano per paura. Paura di rimanere indietro con il lavoro; paura di non sembrare persone che si impegnano abbastanza.
I livelli di ansia a riposo non sono molto migliori in Gran Bretagna. Un recente sondaggio condotto dall'Institute of Leadership & Management su oltre 1.000 lavoratori del Regno Unito ha rilevato che la prospettiva di una vacanza fa sentire stressato il 73% dei lavoratori. E il 61% delle persone si è sentito obbligato a lavorare in ferie.
Colpa della tecnologia? Non proprio.
È aberrante che così tanti di noi trovino traumatico prendersi del tempo libero, ma non è una cosa di cui mi stupisco. La tecnologia ha reso praticamente impossibile ignorare le nostre caselle di posta e concederci una pausa e, a un livello più profondo, il capitalismo ci ha condizionato a valutare noi stessi in base alla nostra produzione. “Produco, dunque sono”, per parafrasare Cartesio.
È normale e salutare trarre uno scopo dal lavoro, ovviamente. Ma la misura in cui idolatriamo la produttività non è sana.
Uno dei motivi per cui ci sentiamo così è perché colleghiamo il nostro comportamento, le nostre prestazioni, la nostra produttività, con la nostra autostima e quindi, quando siamo meno produttivi, ci sembra di fare qualcosa di sbagliato.
Continuiamo a percepire noi stessi in gran parte rispetto al lavoro che facciamo più che alle persone che siamo.
E da fuori veniamo bombardati dal racconto del successo: app per leggere 5 libri al mese consumando bignami, corsi motivazionali che ti fanno diventare “imprenditore di successo” (sempre la maschile, ci mancherebbe), interviste al CEO del suo condominio su come faccia a essere la persona al top che è: corsa alle 5:30 del mattino, 14 ore di lavoro, lavoro dopo cena, ascolto di audiolibri nel sonno. La retorica del lavoro che ami, che fai con passione: io lo faccio eppure lavoro tantissimo, nonostante si dica che “non lavorerai nemmeno un giorno nella vita”.
Il capitalismo ci racconta che se non siamo produttivi allora non possiamo essere degni della “fabbrica capitalista” che poi è lo stesso mondo che abitiamo tutti quanti.
Caleb Fisher on Unsplash
Ma come interagiscono la forza capitalista e il senso di colpa? Uno degli anelli centrali all’esistenza di entrambi è comprendere quale ruolo abbiamo dato al concetto di salute personale: viviamo in un sistema di credenze in cui l’onere alla salute è posto sull’individuo. Siamo noi e solo noi- non cause esterne- che abbiamo il potere di essere (o sembrare) in salute.
E questo ha come conseguenza una percezione falsata di ciò che significa essere sani e del valore che diamo alla salute stessa. Abbiamo la costante pressione sociale di non fermarci, nemmeno quando dovremmo farlo perché non stiamo bene.
Le persone che fanno parte di categorie marginalizzate, come le persone con disabilità o chi ha una malattia cronica, sentono un'ulteriore pressione che chiede loro di mettersi alla prova in una società capitalista che non è solo abile ma anche classista. Una società che considera chi appartiene a un background socio-economico inferiore meno degno di merito sociale. Anche i genitori che lavorano da casa affrontano questo problema, raddoppiandolo. Ci si aspetta che i genitori performino da Oscar dentro e fuori il luogo di lavoro. (Ho scritto genitori ma chiaramente intendo le madri).
Il capitalismo interiorizzato è un nuovo modo di descrivere una vecchia idea
Il concetto di capitalismo interiorizzato non è nuovo ma descrive l'etica del lavoro calvinista, in cui se lavori duramente avrai successo e, più per esteso, ti garantirai la salvezza eterna.
E se ritroviamo questo concetto come più pervasivo soprattutto tra i giovani non stupisce, anche qui, capire perché: pressione sociale, futuro letteralmente impossibile da costruire, insicurezza economica.
Tutti però, in una società capitalista, siamo vulnerabili all’interiorizzazione di idee che collegano il nostro valore a ciò che facciamo piuttosto che a chi siamo anche se la quantità di privilegi su cui possiamo contare spostano decisamente l’asse della questione.
Chi proviene da un ambiente privilegiato può sperimentare il productivity guilt perché teso a ottenere risultati all’altezza delle aspettative famigliari mentre chi proviene da contesti meno privilegiati ha come orizzonte più prosaiche questioni economiche legate alla sopravvivenza.
A seconda della nostra posizione sociale avremo più o meno gradi di potere rispetto a ciò a cui possiamo dire no, ma nella misura in cui abbiamo queste opzioni penso sia giusto chiedersi se ne valga la pena, ricordando che l'obiettivo generale di qualsiasi società dovrebbe essere il benessere, non la produttività. 1
Cosa ho letto ultimamente:
Mostri. Distinguere o non distinguere le vite dalle opere: il tormento dei fan, di Claire Dederer, edito da Iperborea.
Maschiocrazia. Perché il potere ha un genere solo (e come cambiare), di Emanuela Griglié e Guido Romeo, edito da Codice Edizioni.
Del profumo dei croissants caldi e delle sue conseguenze sulla bontà umana. 19 rompicapi morali, di Ruwen Ogien, edito da Laterza.
Cosa sto ascoltando:
La seconda stagione di Humor Nero, di Laura Formenti
Con randomiche incursioni di Angelina Mango, soundtrack dal mondo Disney (genitori, I feel you) e la mia sempreverde playlist Indie Per Cui, che aggiorno quando mi ricordo e che contiene canzoni tristi che (per me) fanno così tanto il giro da donarmi imprevedibili attimi di pura gioia. (sì, questa è una citazione).
That’s all folks,
come si diceva una volta
essendo inclusivə senza saperlo.
Riposate.
Su questo tema, segnalo un bel contenuto dell’amica Sarah Malnerich che potete leggere qui